LE RADIAZIONI IONIZZANTI IN MEDICINA - CENNI
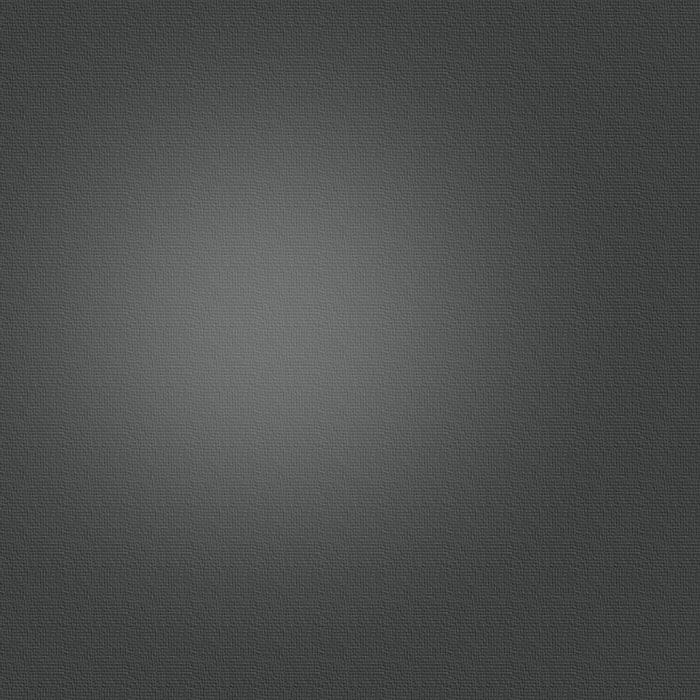


Le applicazioni mediche
Le applicazioni mediche delle radiazioni appartengono a due categorie fondamentali: la radiodiagnostica e la radioterapia. L’uso delle radiazioni nella diagnostica va dalla comune radiografia a raggi X, alla tomografia assiale computerizzata, alla scintigrafia con impiego di traccianti radioattivi, fino a tecniche di minor impatto generale ma di indubbio interesse clinico, come le analisi RIA in vitro e la MOC. Attraverso le diverse tecniche è possibile osservare l’interno dell’organismo umano e i particolari dei diversi organi con livelli di accuratezza e di dettaglio molto elevati, con la possibilità di effettuare diagnosi estremamente accurate di stati patologici altrimenti non verificabili senza intervenire chirurgicamente.
La radioterapia, che sfrutta la capacità delle radiazioni di distruggere i tessuti patologici, è ampiamente utilizzata soprattutto per la cura del cancro. L’ONU stima che nei paesi sviluppati circa il 2 per mille della popolazione sia sottoposta annualmente a pratiche di questo tipo, il che, in un paese con 50 milioni di abitanti, corrisponde in media al trattamento di 100 mila pazienti ogni anno. Negli ultimi anni si sono perfezionate tecniche radioterapeutiche molto accurate basate sull’attivazione di sostanze aventi la proprietà di concentrarsi nei tessuti patologici (ad esempio, boroterapia). Le cellule cancerose vengono in tal modo irradiate selettivamente e dall’interno, interessando in minima parte i tessuti circostanti.
Le apparecchiature che utilizzano le radiazioni ionizzanti in ambito sanitario sono tante e complesse. In tutta generalità e molto sinteticamente a seguire descriviamo i costituenti comuni delle apparecchiature radiologiche utilizzate in radiodiagnostica o in radioterapia con particolare riferimento a quegli aspetti più direttamente connessi alla radioprotezione degli operatori addetti al loro funzionamento. Va tenuto presente che oltre alle apparecchiature radiologiche tradizionali vengono impiegate in medicina macchine complesse come TAC e acceleratori di particelle, nonchè sorgenti radioattive sia per scopi diagnostoci che radioterapici, e la radioprotezione in questo ambito si deve occupare non solo del rischio legato all’utilizzo ma anche alla corretta gestione e smaltimento.
Generalità sui meccanismi di formazione dell’immagine radiografica:
La proprietà più evidente che presentano i raggi X è la capacità di attraversare la materia. Se sul percorso dei raggi X vengono interposti rispettivamente una struttura anatomica e una pellicola, su di essa verrà registrata “l’ombra” della struttura in esame. Alla base, quindi, delle immagini fornite dalle tecniche radiologiche sta il tipo di interazione dei raggi X con la materia, che dipende dalla densità della so- stanza attraversata e dal suo numero atomico. Tessuti di bassa densità, come il polmone e il grasso, lasciano passare più facilmente i raggi X e provocano pertanto sulle pellicole radiografiche annerimenti più consistenti; i tessuti ossei, di alta densità e alto numero atomico, assorbo- no maggiormente i raggi X e lasciano le pellicole meno impressionate, più chiare. Per ridurre la dose al paziente e i tempi di esposizione rendendoli compatibili con il movimento degli organi indagati, la pellicola è racchiusa in una cassetta dotata di “schermi di rinforzo”, vale a dire schermi fluorescenti che, trasformando dei raggi X in energia luminosa, aumentano considerevolmente la sensibilità dei sistemi radiografici. Per rendere visibili organi cavi (vasi sanguigni, stomaco, intestino) è poi possibile effettuare l’indagine dopo la somministrazione al paziente di un “mezzo di contrasto”, cioè una sostanza opaca ai raggi X che evidenzia la cavità rispetto ai tessuti circostanti. L’evoluzione dell’immagine radiografica. Con l’affinamento delle metodiche diagnostiche e l’evoluzione tecnica delle apparecchiature, le immagini ottenute con l’uso dei raggi X hanno subìto costanti miglioramenti (alimentazione ad alta frequenza, riduzione delle dimensioni della macchia focale, anodo rotante, digitalizzazione dell’immagine), con un sostanziale aumento delle informazioni diagnostiche e una decisa diminuzione della dose al paziente attraverso l’uso di schermi di rinforzo alle terre rare, di pellicole ad alta sensibilità, di fasci opportunamente filtrati.
Costituenti comuni delle apparecchiature radiologiche:
Il tubo radiogeno: consta di un’ampolla di vetro in cui è stato creato il vuoto e in cui sono colloca- ti due elettrodi affacciati denominati catodo e anodo; un fascio di elettroni emessi dal catodo per effetto termoelettronico viene accelerato da una differenza di potenziale e colpisce un bersaglio metallico, l’anodo: questa interazione è causa dell’e- missione dei raggi X e del riscaldamento del tubo.
La guaina o cuffia: per evidenti esigenze pratiche ci si trova nella necessità di limitare l’emissione delle radiazioni ad un fascio utile, collimato ed orientato in una precisa direzione: a tale scopo i tubi radiogeni vengono sempre impiegati in “contenitori” denominati “guaine” o “cuffie” che hanno lo scopo, unitamente al sistema costituito dai collimatori e dai diaframmi, di evitare la dispersione di radiazione X non utile all’effettuazione dell’esame o della terapia. Norme di buona tecnica definiscono la massima entità della radiazione di fuga dalla cuffia dipendentemente dalla tipologia di apparecchiatura.
Generatore ad alta tensione: si intende la combinazione di tutti gli elementi per il controllo e la produzione dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione di un tubo radiogeno; comprende necessariamente un trasformatore di alta tensione e un sistema di controllo. Un tubo radiogeno utilizzato in una attività diagnostica, infatti, funziona con tensioni comprese tra circa 25 kVp e circa 150 kVp, mentre un tubo radiogeno utilizzato in terapia può arrivare a circa 300 kVp. La tecnologia mette a disposizione vari tipi di generatori (sistemi trifase, triesafase, dodecafase, a scarica di condensatore, ad alta frequenza).
Tavolo di comando: è quel componente dell’impianto radiologico nel quale sono raggruppati tutti gli organi elettrici di regolazione e controllo dei dati di esposizione, gli eventuali dispositivi di sicurezza necessari alla protezione dei circuiti elettrici e del tubo da eventuali sovraccarichi e i dispositivi di comando dell’emissione raggi. I principali parametri impostabili dal tavolo di comando sono:
– il valore dell’alta tensione (in kVp), che determina la qualità della radiazione emessa dal tubo radiogeno;
– il valore della corrente del filamento (in mA) che determina, a parità di kVp e di durata dell’esposizione, la quantità di fotoni X emessa
dal tubo radiogeno;
– la durata dell’esposizione.
L’intensificatore di brillanza (I.B.) e la catena televisiva: alcuni materiali, interagendo con le radiazioni ionizzanti, presentano la proprietà di emettere luce (fluorescenza): tale fenomeno è alla base di tutte le attività diagnostiche che utilizzano gli schermi fluorescenti; l’intensità della luce emessa da tali schermi è sempre molto bassa in rapporto alle capacità visive dell’occhio umano: gli intensificatori di brillanza sono dispositivi elettronici che hanno la funzione di accrescere il livello luminoso dell’osservazione per portarlo a condizioni più favorevoli per l’occhio umano. La radiazione X, dopo aver attraversato il paziente, investe la finestra d'ingresso dell’intensificatore di brillanza, dietro la quale è posto un fotocatodo; questo, investito dai fotoni, emette elettroni che vengono accelerati e focalizzati da lenti elettroniche verso lo schermo fluorescente posto sulla finestra d’uscita. Il segnale d’uscita, amplificato varie volte grazie all'accelerazione degli elettroni e alla riduzione del campo di vista, può essere visualizzato tramite una opportuna catena elettronica su uno schermo televisivo. L'immagine analogica ottenuta può essere trasformata in immagine digitale e successivamente memorizzata in un computer per una eventuale elaborazione. Un tipico esempio è costituito dal procedimento di sottrazione d’immagine in angiografia digitale.
Gli impieghi più comuni delle radiazioni ionizzanti in medicina possono essere per singole voci così sintetizzati:
-
-radiologia tradizionale
-
-mammografia
-
-tomografia computerizzata
-
-radioscopia e radiologia interventistica
-
-radiologia dentale
-
-mineralometria ossea computerizzata
-
-radioterapia


GammaRay © Copyright 2022
